Cos’è il dolore: gestione e prevenzione
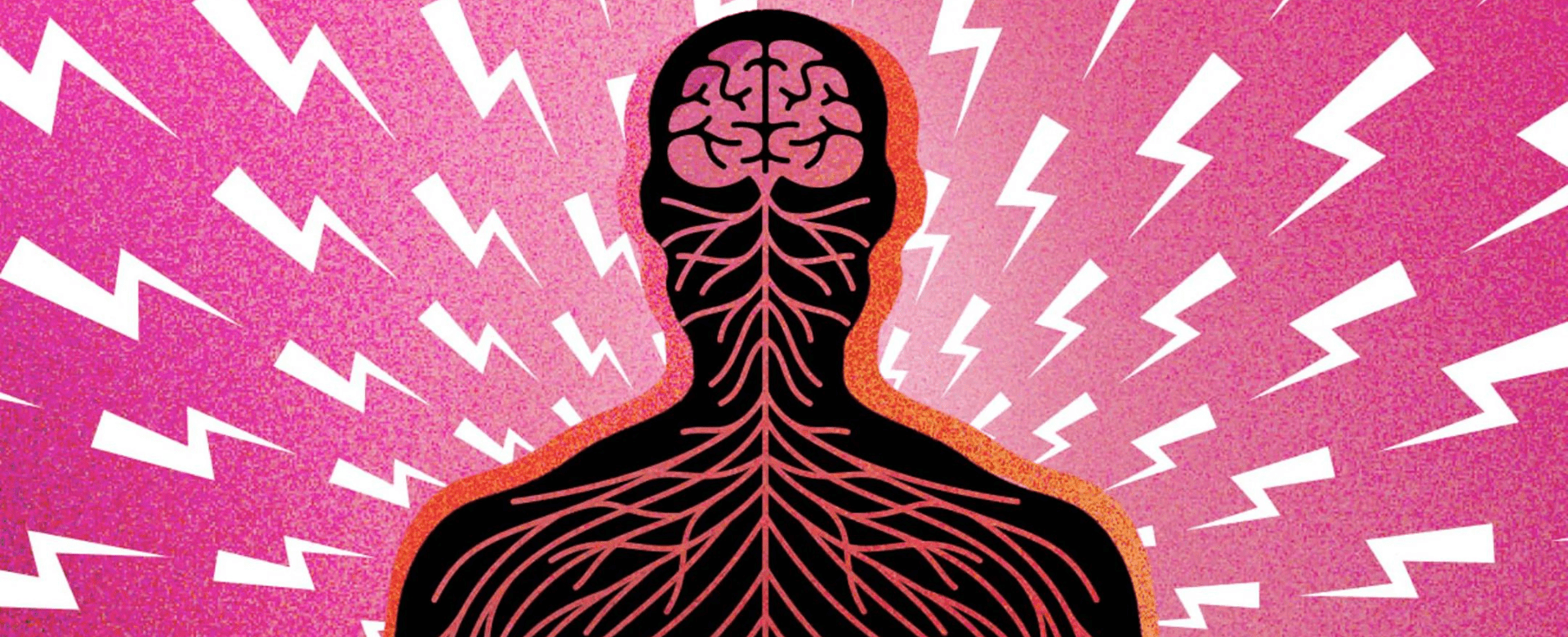
Vi è mai capitato di provare dolore? Cos’è il dolore? Può essere associato a qualcosa come il pizzicotto che viene percepito quando l’infermiere preleva il sangue dal braccio o quando viene percepito un blocco a livello lombare dopo essere stati seduti per tutto il giorno?
Il dolore è stato descritto dalla IASP (International Association for the Study of Pain) come “un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole, associata ad un danno tissutale o potenziale, o descritto in termini di tale danno”.
Si evince dunque che il dolore non si tratti solo di un’esperienza sensoriale, ma anche emozionale. Quindi non dipende solo dagli stimoli meccanici esterni, ma anche dalla componente personale soggettiva, in cui rientrano le esperienze passate, la gravità percepita, il contesto in cui tali esperienze sono inserite.
Il dolore è uno dei mezzi più efficaci che ha il nostro corpo nel perseguire il suo principale obiettivo, la sopravvivenza, e deve la sua efficacia proprio alla sua “spiacevolezza”.

Modulare il dolore
Come si genera il dolore fisiologicamente? Quando si crea un danno vengono rilasciate sostanze chimiche che attivano i nocicettori, sentinelle che segnalano un danno tissutale al sistema nervoso. Quando un numero sufficiente di neuroni viene attivato il segnale viene trasmesso al midollo spinale, precisamente nel corno posteriore del midollo, passa nel canale centrale e viene elaborato dai fasci anteriori. A questo punto lo stimolo sale e arriva ai centri del dolore dell’encefalo, che ce lo fanno percepire così come lo conosciamo.
Al contrario, quando lo stimolo dolorifico termina il nostro cervello vuole mandare segnali di inibizione del dolore, lo stimolo parte dall’encefalo e percorre un’altra via, che finisce sempre nel corno posteriore. Questo stimolo percorre le vie discendenti, che possono essere modulate.
Risolta la causa che attiva i nocicettori, come può essere un’infiammazione acuta da trauma, e concluso il loro allarme, il dolore cesserà, perché i nocicettori saranno disattivati dalla via discendente.
Esistono 3 tipi principali di dolore:
- Nocicettivo: il tipo di dolore attivato da un danno. La nuova definizione sdogana l’obbligo di danno e lascia spazio ad altre fonti di innesco del dolore, che quindi non è più solo nocicettivo, ma può essere anche:
- Infiammatorio: causato da un’infiammazione in atto e dall’attivazione del sistema immunitario.
- Patologico (neuropatico): non si tratta più di un dolore che nasce da un istinto protettivo, bensì maladattativo. Il dolore è dato da un danno a livello del sistema nervoso oppure da un suo malfunzionamento.
Ma se lo stimolo nocicettivo crea un danno che non si risolve in breve termine, cosa succede? Si crea infiammazione locale, vengono prodotte molecole infiammatorie e i nocicettori vengono attivati chimicamente e rimangono attivi finché l’infiammazione non si è risolta.

Tuttavia si può cadere in una situazione dove esiste l’infiammazione senza un danno iniziale. Non c’è un evento scatenante che determina l’inizio dell’infiammazione, ma è un insieme di fattori che possono dipendere anche dai nostri comportamenti e stili di vita che possono creare infiammazione sistemica, ovvero infiammazione generale di tutto il corpo.
Una grossa fetta dei dolori cronici è rappresentata da questa causa e il principale responsabile dell’infiammazione in questi casi è il mitocondrio, organello presente all’interno di ogni cellula che si occupa della respirazione cellulare.
Durante il processo di produzione di energia vengono generate delle molecole che innescano l’infiammazione, i ROS (specie reattive dell’ossigeno).
I ROS sono il link tra infiammazione e dolore. Elevati livelli spinali di ROS possono alterare la nocicezione portando a ipereccitabilità del Sistema nervoso centrale e periferico senza danno a nervi, tessuti o infiammazione locale. Sono molecole pro-ossidanti che, se prodotte in eccesso, hanno effetti dannosi sul nostro organismo e la cellula entra in uno stato chiamato stress ossidativo, che può portare danno ai lipidi, proteine e DNA.
Questo ci porta a capire che maggior stress ossidativo significa maggiore infiammazione e quindi dolore.
Abbiamo una difesa naturale contro i ROS, gli antiossidanti. Ecco che chi ha dolore cronico tende ad avere uno squilibrio tra ossidanti e antiossidanti e che quindi questo rapporto può avere un ruolo nella trasmissione del dolore.
Se il dolore persiste per tanto tempo l’organismo può andare incontro a quella che viene definita “sensibilizzazione centrale”, fenomeno che vede un aumento della risposta di questi neuroni: la neuromatrice diventa iperreattiva e questo risulta poi in un sistema nervoso a sua volta iperreattivo. Quindi, da una parte il sistema nervoso è più incline a mandare messaggi di allarme attraverso il dolore e dall’altra sarà meno incline a inibirlo.
Anche in questo caso è l’infiammazione prolungata (sia locale sia sistemica) a creare questa disfunzione al sistema nervoso. Quindi, un danno ripetuto può essere fonte di sensibilizzazione, ma anche un rilascio di citochine infiammatorie costante può modulare il dolore.
In più bisogna menzionare anche un certo ruolo alla psicologia in tutto questo. È stato evidenziato che atteggiamenti di catastrofizzazione e non accettazione del dolore possono inibire le vie discendenti di inibizione del dolore.

Strategie per far fronte al dolore
Quali armi abbiamo per combattere questo tipo di dolore? Su quali piani possiamo agire?
La componente dell’alimentazione è indispensabile per ridurre l’infiammazione che uno stile alimentare scorretto porta e quindi la primissima causa di dolore cronico non specifico. Ci sarebbero un milione di cose da dire ma semplificando il più possibile si può dire che una dieta preventiva dovrebbe essere moderata (quindi che non sia ipercalorica), varia, si può facilmente intuire cosa significhi quindi, fare largo consumo di tutta la verdura facendo attenzione alla stagionalità, ruotare le proteine giornalmente utilizzando uova, legumi, prodotti lattiero-caseari, specialmente fermentati, pesce e carne, preferendo la bianca alla rossa; che tenga conto della riduzione degli zuccheri semplici e che tutti i pasti siano costituiti da fonte di proteine, grassi, carboidrati complessi e fibre.
Inoltre è ormai noto che, in generale, l’aumento dell’attività fisica crea un beneficio alle patologie muscoloscheletriche croniche e questo deve esservi ben chiaro in mente. La sedentarietà è il nemico da combattere. L’esercizio fisico si è dimostrato più efficace nel ridurre la sintomatologia dolorosa di qualsiasi terapia conservativa.
Sembrerebbe che i 3 tipi di esercizio che più aiutano nella riduzione del mal di schiena siano: pilates, una tipologia di allenamento che viene chiamata stabilization motor control, ovvero esercizi di stabilità che utilizzano esercizi posturali di mantenimento di specifiche posizioni e l’esercizio aerobico.
Questi tre tipi di modalità di esercizio sono diversissimi tra loro e agiscono su meccanismi completamente diversi. Com’è possibile che tutti e tre siano efficaci nella riduzione di uno stesso dolore?
Qualsiasi esercizio di intensità moderata è efficace nella riduzione del dolore cronico perché aumenta il flusso sanguigno e va ad agire sul microcircolo, migliorando la funzionalità endoteliale e mitocondriale, facilitando il trasporto di nutrienti ai tessuti.
È necessaria quindi una iniziale educazione al dolore, che abitui il soggetto a percepire che muoversi è possibile senza necessariamente percepire discomfort e fastidi. La rimodulazione degli stili di vita, in particolare a livello di attività fisica e movimento sono le principali strategie di riduzione del dolore percepito, in ottica di benessere e salute.
