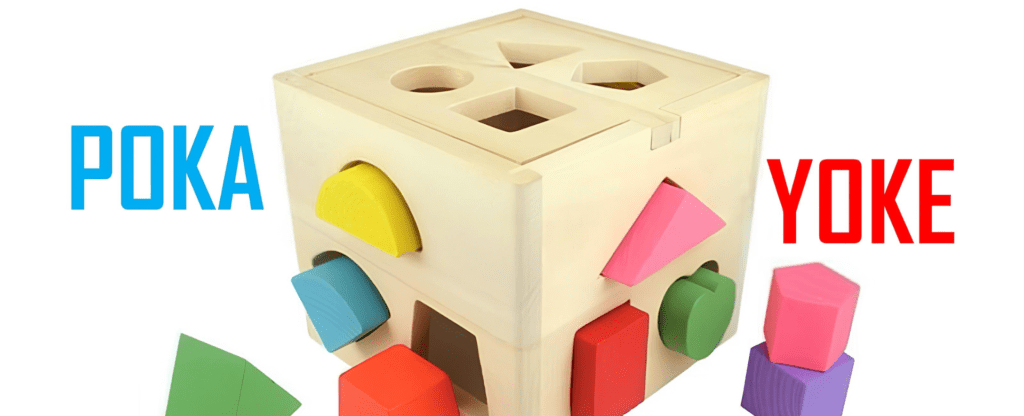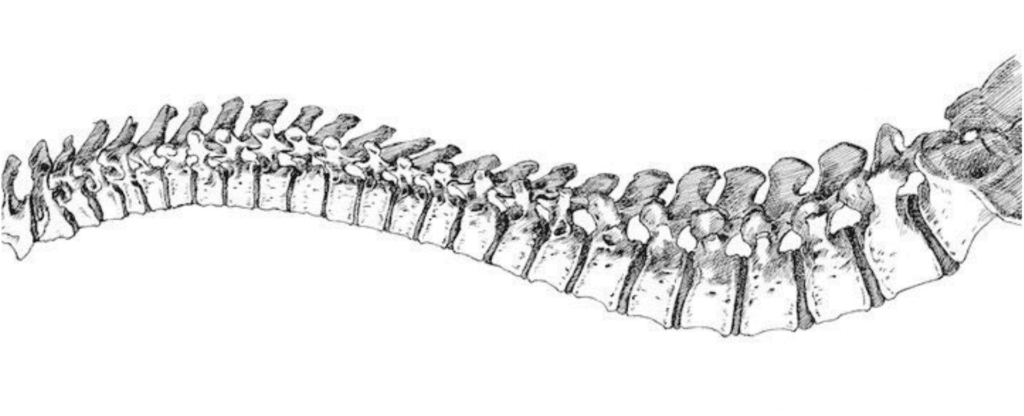Disturbi muscoloscheletrici e soddisfazione lavorativa

L’evoluzione degli ambienti lavorativi negli ultimi decenni, caratterizzata dalla crescente diffusione del lavoro d’ufficio e dall’utilizzo intensivo di dispositivi tecnologici, ha determinato un incremento significativo dell’incidenza di disturbi muscoloscheletrici (MSD) tra la popolazione lavorativa. Tali patologie, che interessano prevalentemente le regioni cervicale, scapolare e lombare, sono riconducibili a molteplici fattori eziologici, tra cui posture scorrette mantenute per tempi prolungati, caratteristiche ergonomiche inadeguate delle postazioni di lavoro e organizzazione del lavoro non ottimale. La letteratura scientifica evidenzia come queste condizioni, se non adeguatamente affrontate, possano evolvere verso forme croniche, con conseguenti ripercussioni negative sia a livello individuale – in termini di ridotta qualità della vita – sia a livello organizzativo, attraverso l’aumento dei tassi di assenteismo e la diminuzione della produttività. Tuttavia, studi recenti dimostrano che l’implementazione di soluzioni ergonomiche evidence-based, comprendenti sia interventi fisici sulle postazioni lavorative sia modifiche organizzative, può efficacemente contrastare tali problematiche.
I MSD hanno un’eziologia multifattoriale. Tradizionalmente i MSD sono stati associati a fattori di rischio occupazionali prettamente fisici, ma esistono molti fattori di rischio psicosociali (PSRF) che possono aumentare la possibilità di sviluppare un disturbo lavoro-correlato. I PSRF sono definiti come quegli aspetti della progettazione, organizzazione e gestione del lavoro che all’interno del contesto sociale e ambientale, possono potenzialmente causare danni psicologici o fisici. In effetti, rispetto alle condizioni di lavoro di 50-70 anni fa, si può osservare chiaramente un aumento significativo dei PRSF. L’impatto crescente di questo tipo di rischio ha a che fare con le nuove condizioni di lavoro, come la maggiore velocità dei processi di produzione, l’aumento della percentuale di lavoro intellettuale, la tendenza verso una società basata sui servizi, una crescente complessità delle richieste e l’instabilità del lavoro.
Come accennato in precedenza, condizioni di lavoro non soddisfacenti e incertezza lavorativa sono fattori che possono contribuire all’aumento di MSD nella popolazione lavorativa, come dimostrato negli studi di Bazazan et al. e Loghmani et al.
La letteratura scientifica evidenzia come soluzioni interventi ergonomici strutturati – comprendenti sia adeguamenti fisici dell’ambiente lavorativo sia modifiche organizzative – per costituire un approccio efficace in grado di contrastare tale fenomeno.
Il legame tra PSF e salute fisica è stato analizzato fin dai primi anni ’80 da Karasek & Theorell con il “modello stress lavoro-correlato” in cui viene descritto come un equilibrio tra le richieste psicologiche del lavoro e il livello di controllo del lavoratore su di esse: maggiori sono le richieste e minore è il controllo, più probabile è il rischio di stress e l’effetto negativo sulla salute.
Un altro modello che tocca questa problematica è il “modello dello stress biopsicosociale” di Merling & Lundberg. Essi sostengono come lo stress psicologico non è indotto solo da richieste che superano le risorse dell’individuo, ma anche da situazioni opposte, come lavori monotoni e ripetitivi.
In relazione a questo, Lundberg et al. (1989) avevano precedentemente condotto uno studio sperimentale in cui concludevano che i fattori psicosociali come la scarsa soddisfazione e la monotonia sul posto di lavoro avevano un’influenza più significativa sulla sintomatologia dorsale rispetto alla cattiva postura e al trasporto di pesi.
Uno studio che ha analizzato in modo approfondito l’associazione tra Disturbi Muscoloscheletrici e fattori di rischio psicosociali nel luogo di lavoro è stato fatto da Hales & Bernard in cui hanno evidenziato tre meccanismi che possono incidere su questi due fattori:
- le richieste psicologiche potrebbero superare i meccanismi di difesa dell’individuo e indurre una risposta allo stress che potrebbe aumentare la tensione muscolare.
- le richieste psicologiche potrebbero potrebbero aumentare la consapevolezza della sintomatologia dei DMS e la loro attribuzione al contesto lavorativo.
- In alcune situazioni lavorative, le richieste psicologiche potrebbero essere correlate all’aumento delle richieste fisiche, che potrebbero anche avere un impatto sui sintomi.
I rischi psicosociali più frequentemente associati a questa sintomatologia sono l’elevato carico di lavoro, lo scarso controllo, la mancanza di supporto sociale, la tensione sul posto di lavoro, la pressione del tempo e il lavoro monotono.
Agire attraverso interventi ergonomici può ridurre le sintomatologie dolorose e migliorare la produttività: ambienti lavorativi progettati con criteri ergonomici, non solo prevengono disturbi fisici ma promuovono il benessere e la performance dei lavoratori. Questo lo dimostra uno studio di Gonzalez & Co, pubblicato su Human Factors and Ergonomics, che ha dato un contributo significativo alla letteratura sull’ergonomia organizzativa (in cui ne abbiamo già parlato nello scorso articolo), indagando sistematicamente le relazioni tra flessibilità lavorativa, benessere dei dipendenti e performance organizzativa. Lo studio sottolinea l’importanza di approcci evidence-based nella progettazione degli ambienti lavorativi, dimostrando come investimenti mirati in ergonomia possano generare simultaneamente benefici individuali e organizzativi.
A livello concreto, possiamo ritrovare questi concetti in tre step:
- Per prevenire i MSD si può andare ad intervenire ergonomicamente agendo sulle postazioni lavorative, formando e consapevolizzando i lavoratori su queste problematiche.
- Migliorando il comfort fisico di conseguenza aumenta la soddisfazione lavorativa, con ricadute positive sull’efficienza.
- Favorire un approccio integrato in cui si combinano soluzioni fisiche (come arredi) e organizzative (pause, smart working) per ottimizzare i risultati.
In conclusione un approccio sistemico all’ergonomia lavorativa rappresenta un requisito imprescindibile per la promozione della salute occupazionale. I dati empirici esaminati nei diversi studi dimostrano in modo inequivocabile l’esistenza di una correlazione negativa tra l’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici, la soddisfazione lavorativa e i parametri di produttività. In particolare, emerge con chiarezza che interventi ergonomici integrati – comprendenti sia l’ottimizzazione delle postazioni lavorative sia l’implementazione di flessibilità organizzativa – producono effetti positivi significativi sia sul benessere fisico dei lavoratori sia sull’efficienza organizzativa. Questi risultati sottolineano la necessità di adottare un paradigma proattivo nella gestione della salute lavorativa, che vada oltre la necessità normativa per abbracciare una visione olistica del benessere organizzativo.
L’implementazione di tali soluzioni non costituisce semplicemente un investimento in salute, ma rappresenta una strategia win-win in grado di generare vantaggi competitivi sostenibili per le organizzazioni. Alla luce di queste considerazioni, si rende evidente come la progettazione di ambienti lavorativi centrati sul lavoratore, basati su evidenze scientifiche e principi ergonomici, debba essere considerata una priorità all’interno di tutti gli ambienti lavorativi.
Bibliografia
- Mateos-Gonzalez, L., Rodríguez-Suárez, J., & Llosa, J. A. (2024). . A systematic review of the association between job insecurity and work-related musculoskeletal disorders. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 34, 79–99. https://doi.org/10.1002/hfm.21013